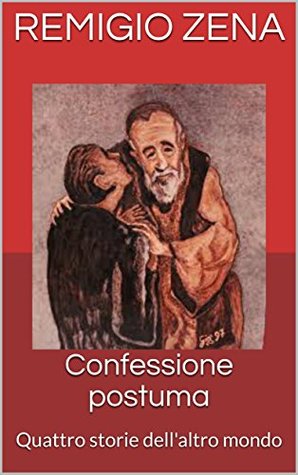Antologia dell’inconsueto: “48 Morto che parla”
In questa antologia abbiamo già affrontato sia il verismo che la scapigliatura e se questa corrente letteraria è un’invitata la cui presenza non stupisce, il verismo è sempre un piacevole quanto inaspettato ospite.
Per questo non può mancare Gaspare Invrea (1850-1917), alias Remigio Zena (costretto allo pseudonimo perché appartenente a un’importante famiglia ligure), che fa dei suoi scritti un ponte tra le due correnti.
Con la raccolta di racconti postuma “Quattro storie dell’altro mondo”, di cui scegliamo “La confessione postuma”(1897), l’autore vuole documentare un interesse, quello per l’occultismo, in piena stagione verista. Forse anche con qualche intento divulgativo.
In questo particolare racconto avvengono due cose “strane”: il fratello del protagonista (medico) durante il sonno manda il suo “spirito” – o sarebbe meglio dire “corpo astrale” – a guidare il fratello (sacerdote) per le vie della città, per raccogliere la confessione di una sventurata che non è riuscita a morire “in grazia di Dio”. Questa era la prima cosa “strana”; la seconda è che la ragazza effettivamente si confessa al sacerdote. Abbiamo quindi un’anima che lascia il corpo nel sonno e una che torna ad abitarlo dopo la morte.
Gasparre Invrea a differenza degli scapigliati aveva combattuto, durante il Risorgimento, tra le file del Papato. Era fortemente religioso e in particolare provava un forte interesse per le teorie di Emanuel Swedenborg (1688-1772), religioso e mistico: durante il sonno faceva esperienze di contatto con angeli e defunti.
Lo spirito può, nelle teorie di Swedenborg, a seconda dei suoi desideri e comportamenti, frequentare gradi alti o bassi del mondo spirituale: nel nostro caso il fratello del protagonista, spinto dalla misericordia verso una fanciulla sventurata, desideroso di salvarle almeno l’anima, riesce a separarsi dal corpo e a guidare il fratello al cadavere di lei, perché riceva l’assoluzione. Una cosa interessante è che (se particolarmente meritevole) l’anima serba ricordo del suo viaggio, o parte di questo. Il fratello medico ricorda distintamente che qualcuno ha suonato alla porta dell’appartamento mentre lui dormiva e nulla più, ma questo nel racconto funziona come una conferma dell’accaduto: altre prove della veridicità dell’esperienza giungono più tardi, il che porta il protagonista a scrivere a un superiore.
Il racconto è in forma epistolare, leggiamo la lettera che il sacerdote invia al suo mentore. Non vivendo l’azione in prima persona, ma sentendo il racconto, possiamo sospendere il nostro giudizio e rimanere scettici rispetto quanto accaduto.
Tutte le opere di Remigio Zena sono disponibili su Liber Liber
Confessione postuma
Mi perdoni, Monsignore reverendissimo, se nello stato di turbamento ineffabile nel quale mi trovo, ardisco rivolgermi a lei, chiedendo aiuto e consiglio. Prima di confidarmi ad altri, che forse riderebbero di me trattandomi d’allucinato e di visionario, dalla sua carità paterna imploro quella pace al mio Spirito che altri non saprebbero darmi; e nel nome di Nostro Signore Gesú Cristo l’imploro fiducioso, in memoria della benevolenza tutta speciale onde lei si compiacque onorarmi per tanti anni, e che fu il tesoro della mia adolescenza e della mia giovinezza, fin dal giorno che, per grazia divina indegnamente ascritto alla milizia della Chiesa, tremando e giubilando, offersi la prima volta il santo Sacrifizio.
Padre, padre mio, mi ascolti e mi illumini. Colla mente mi inginocchio ai suoi piedi e le apro tutta l’anima mia.
Che talvolta, per altissimi fini imperscrutabili della sua giustizia e della sua misericordia, Iddio interrompa le leggi naturali, servendosi di mezzi che la nostra vana scienza e il nostro orgoglio e la nostra miseria non possono comprendere né spiegare, la fede ce lo insegna, come ce lo insegnano
le Sacre Scritture e innumerevoli esempi anche attuali, sotto i nostri stessi occhi: ma non è men vero che pure il demonio, quaerens quem devoret, non di rado usa in danno delle anime artifici meravigliosi, che hanno l’apparenza di miracoli e dai quali facilmente i deboli o gli ignoranti restano affascinati e indotti al peccato: prova ne siano le vite dei santi, che ad ogni passo riboccano di simili tentazioni stupefacenti, e anche al giorno d’oggi i fenomeni dello spiritismo che menano tanto scalpore perfino fra i dotti, e che la «Civiltà Cattolica» negli ultimi fascicoli di questi mesi combatte vittoriosamente, smascherandone la nequizia, rivelandone l’origine diabolica.
Ora, se io fossi giuoco del maligno? Per quanto negli avvenimenti strani che sto per raccontarle – e dico strani, poiché altro vocabolo piú significativo in questo momento non mi soccorre – io non sia capace nella mia ignoranza di ravvisare l’insidia, chi mi dà la certezza che, in penitenza forse dei miei falli, Iddio non voglia sottopormi a una terribile tentazione?
Penso con terrore che la notte si approssima. Ho pregato e pianto ai piedi del Crocifisso. Padre mio, preghi per me e mi illumini e consoli. Stamattina nel celebrare la santa Messa, usai invano ogni sforzo per espellere dall’anima mia i pensieri insistenti che la turbavano; non fu se non durante il Canone, che alla presenza reale di Nostro Signore, annientandomi nell’adorazione eucaristica, si dissiparono per pochi minuti, come se le anime che tormenta il fuoco di purificazione, mi avessero ottenuto di poter intercedere per esse con fervore nel memento dei morti.
In nome di Dio, ella che tante volte e con ammonimenti paterni mi aiutò a trionfare degli scrupoli che mi assalivano, non mi creda vittima di una allucinazione prodotta appunto da scrupoli o da soverchi esercizi di pietà: ho perfetto criterio del mio stato d’animo, la mia memoria è limpida, senza intervalli e senza lacune, tanto limpida e netta che di queste ultime quaranta ore rivedo lo specchio minuto per minuto, e nel riaffacciarsi alla mente d’ogni mio atto, ad una ad una torno a
provare le medesime sensazioni.
A questo tavolino dove adesso le sto scrivendo, ier l’altro a sera terminavo di recitare l’Uffizio. Erano da poco suonate le undici. Mio fratello, che è medico assistente all’Ospedale Maggiore e dorme nella stanza attigua alla mia le notti che non è di guardia, da circa mezz’ora aveva spento il lume, contro il suo solito di vegliare, studiando, fin dopo il tocco. Appena un momento era entrato da me per dirmi che la visita di Sua Eminenza il nostro Arcivescovo all’ospedale avrebbe avuto luogo la mattina seguente in forma solenne, e andando con lui mi sarebbe stato facile unirmi agli altri ecclesiastici del corteggio; poi si era subito ritirato affranto dalla fatica e assai commosso per la morte avvenuta quella sera d’un’inferma del suo riparto, una povera giovinetta tedesca, orfana e abbandonata, alla quale per un sentimento di compassione grandissima aveva dedicato in modo speciale tutte le sue cure, fin dal primo giorno che l’aveva vista vaneggiante nel delirio d’una febbre tifoidea senza perdono.
Ero giunto all’ultimo versetto del Benedictus: illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent, e rammento che quelle parole di consolazione le ripetei due volte come un suffragio all’anima dell’estinta, cui il delirio continuo aveva impedito di riconciliarsi con Dio; nella ferma fiducia che anche a costo di un prodigio, la misericordia infinita l’avrebbe salvata attraverso le tenebre della morte, quando udii repentinamente, nel gran silenzio, uno squillo al campanello della porta di casa.
Chi poteva essere a quell’ora? Mi alzai e con ambe le mani reggendo la lampada a petrolio, andai ad aprire. Nessuno. Non ne feci meraviglia; già altre volte, massime in campagna, mi era occorso di udire dei falsi suoni o delle false voci nel cuore della notte, proprio dentro la camera mia, sulla mia testa, all’orecchio, e pronto a giurare d’avere realmente e distintamente udito; dover poi riconoscere che l’immaginazione mi aveva ingannato. Tranquillo, tornai a riprendere da capo la recita del salmo, ma pure avendo il breviario aperto sotto gli occhi, a tutta prima non seppi raccapezzarmi, la memoria mi falliva e non trovavo il testo sul libro, offuscato da un velo di nebbia. La lampada agonizzava; alzai il lucignolo e stetti qualche momento in contemplazione della fiamma risuscitata, come davanti a un simbolo.
Illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent. Nei giorni precedenti avevo purtroppo inteso da mio fratello chi fosse colei che da Vienna era venuta in Italia a morirvi nell’abbandono, e perché fosse venuta e di quali ghirlande profane avesse infiorato la sua misera giovinezza. O Signore, non c’era piú dunque per lei speranza di risurrezione? Non soltanto dagli uomini era stata abbandonata, anche da voi, Signore, anche da voi, o clementissimo e misericordioso, umanato per lei, crocifisso per lei? Un attimo le sarebbe bastato per conoscervi e impetrare la sua remissione, e quest’attimo di luce voluto dal vostro sangue sparso, non le sarebbe stato concesso mai piú, per tutta l’eternità, se incosciente era trapassata dall’agonia nella morte senza averlo potuto ottenere?
Padre, un nuovo squillo risuonò nel silenzio, piú acuto del primo ed altrettanto inaspettato. No, questa volta non era una illusione della mia fantasia. Tuttavia non mi mossi subito: quand’ecco spegnersi la lampada all’improvviso, come fulminata da un soffio d’uomo. Tra il sonno e la veglia, mio fratello chiamò: «Pietro, vai tu ad aprire? hanno suonato due volte»; segno che lui pure aveva udito la prima e la seconda scampanellata. Risposi: «Vado io, dormi tranquillo» e levatomi in piedi, cercai a tentoni sull’inginocchiatoio accanto al letto i fiammiferi e un pezzetto di candela che mi serve ogni mattina per vederci a scender le scale. Senonché, urtando colla mano, feci cadere un piccolo Crocifisso, quello stesso, Monsignore, che ebbi da lei in prezioso dono il giorno della mia ordinazione; lo raccattai da terra all’oscuro, mi accorsi che nella caduta se n’era staccato il piede, e senza pensare a posarlo, accesa la candela, tornato nel vestibolo, adagio adagio, per non isvegliare mio fratello che certamente si era riaddormentato, apersi di nuovo la porta. Nessuno! Chiesi nel
buio: «Chi è là?» Nessuno rispose. Non c’era dubbio: qualche biricchino maligno, introdottosi di straforo su per le scale, che si pigliava il pessimo gusto d’una burletta; e poiché s’era messo all’opera, non vedevo ragione che si stancasse cosí presto, se da parte mia gli lasciavo piena libertà di sbizzarrirsi alle mie spalle.
Salii ai due piani superiori, ridiscesi, e un gradino dopo l’altro mi trovai abbasso in fondo alla scala, senza essermi intoppato con anima viva. La portineria era deserta, ma il portone rimasto socchiuso, attraverso il quale penetrava dalla strada il riverbero d’un fanale, indicava abbastanza che l’amico aveva avuto agio, distrattamente e a passi leggerissimi, di darsela a gambe, appena subodorata la mia intenzione. Fuori, come se ci fosse un uomo in agguato contro il muro, mi parve di scorgere, per la breve apertura, un’ombra immobile sulle lastre bianche del marciapiede.
Ella non mi crederà, padre reverendo, e non credetti io stesso ai miei occhi, quando nell’uomo che aspettava riconobbi mio fratello.
Volli interrogarlo: perché era disceso anche lui? come aveva fatto in cosí breve a vestirsi e passarmi davanti, invisibile? Non rispose. Eppure era lui, Claudio, Claudio mio fratello, nei medesimi panni che indossava un’ora prima in camera mia; e se anche avessi potuto sospettare la piú strana delle rassomiglianze con un ignoto, il suo sguardo mi avrebbe tolto ogni dubbio. L’interrogai di nuovo, pieno d’ansietà: perché era sceso e come mai non l’avevo veduto? si sentiva male? voleva che io l’accompagnassi? Non rispose o meglio, io non lo compresi: dal movimento delle labbra, forse parlava, ma la sua voce non aveva metallo e le sillabe svanivano in un soffio, mentre, d’un pallore algido, mi fissava immobilmente e le sue pupille, fatte d’acciaio, mi penetravano nel midollo delle ossa.
Atterrito, non dubitando piú che fosse stato colto da un malore subitaneo, feci per afferrargli la mano e ricondurlo in casa; ma quantunque vicinissimo a lui, le mie mani non lo raggiunsero, caddero nel vuoto, quasi avessero tentato di stringere un’ombra.
C’era una volontà nei suoi occhi. Senza una parola, senza un gesto, fissandomi sempre, si mosse verso un vicolo oscuro, di rimpetto alla nostra casa. Gridare, perché alcuno lo trattenesse? Ad onta di sforzi inauditi per chiedere soccorso ai passanti, la mia voce ribelle si raggruppava quasi soffocata nella strozza, come in un sogno penoso, quando non ci riesce di prorompere in quel grido supremo che sarebbe la liberazione. I pochi solitari che transitavano, correndo pel loro cammino, taluni passandoci accosto, non si volgevano neppure. E da quella volontà mi sentivo soggiogato inesorabilmente, trascinato, ossesso, nella plenitudine della mia coscienza. Non era tempo d’aver paura né angustia, bensí di obbedire al mistero: Claudio s’inoltrava nelle tenebre e voleva che io lo seguissi!
Dove? Camminando alla mia destra, rigido, quasi statuario, egli mi precedeva d’alcuni passi.
Se mi ero arrischiato in principio a un tentativo di resistenza, poi, goccia a goccia, piovendomi dentro il cervello il fluido igneo del suo sguardo mi aveva debellato; era compiuto l’esorcismo, e stretta la gola da un collare di ferro, la suggestione si risolveva in una forza meccanica, alla quale acconsentivo per abbandono, cane al guinzaglio, sebbene non piú sotto l’immediata impressione del fascino. Un labirinto di vie strette e tortuose, tutte eguali, tutte dormenti, che non sapevo riconoscere da verun indizio, e dove mi sembrava di non essere passato mai; ogni tanto il noto profilo di una chiesa o d’un monumento o d’un palazzo si disegnava confuso nell’oscurità. Ma come avevo perduto il criterio dei luoghi, cosí siffatte apparizioni fugaci e saltuarie, balzanti fuori scompigliate, in tutt’altro ordine topografico da quello che mi aspettavo, invece d’essermi guida non facevano che maggiormente sviarmi.
A capo scoperto, senza mantello, tremavo e battevo i denti sotto l’aria gelida di queste notti di novembre; e per una inconcepibile astrazione mentale, piú del freddo e piú del mistero onde ero trascinato all’ignoto, era il rispetto umano che m’angustiava, il timore d’esser visto a quell’ora, io, prete, a quell’ora, vagabondo per le strade in simile arnese! Come avvenne che di quanti trovammo sul nostro cammino, non uno, passando, ebbe curiosità di darmi un’occhiata, e giunti a un crocicchio poco piú largo di questa stanza, nell’attraversare una comitiva di schiamazzatori nottambuli, che cantavano a squarciagola in crocchio sotto un lampione, non uno, fra tanti avvinazzati, volse il capo dalla nostra parte ne fece atto d’essersi accorto del prete? fu nel momento in cui m’attendevo senza fallo ai loro frizzi ed anche alle loro contumelie, che mi sovvenni del Crocifisso, e non so dire se per salvaguardia ovvero per nasconderlo, lo strinsi al petto.
Quanto a mio fratello, ei badava a camminare sempre, senza voltarsi a guardare se veramente io lo seguissi. Piú ora ci penso, meno so rendermi conto della mia dedizione cosí plenaria alla sua volontà, da non preoccuparmi punto dove tendeva quella scorribanda notturna, quando sarebbe finita, come sarebbe finita, e da non avvertirne l’anomalia, se non rispetto alle cose esteriori. Dopo infinite giravolte, di botto Claudio si fermò davanti a una porticina dissimulata nello zoccolo di un fabbricato immenso che fiancheggiava tutta quanta la via; ne spinse l’uscio col semplice appoggio delle
palme, entrammo in una specie d’andito, alla cui estremità, lontanamente, appariva un lume in cima a una scala che salimmo. Non rammento bene se fu nel percorrere il braccio di un cortile a grandi arcate, traversando un altro andito piú lungo e chiaro del primo, che due uomini ci si fecero incontro, vestiti alla stessa foggia, d’una palandrana, e tirarono dritti, senza guardarci, come se non ci avessero veduti. Cosí avvenne d’un terzo che, nell’ultimo corridoio, chiusa a chiave una porta, si allontanò canticchiando, mentre Claudio anche quella porta riapriva col semplice appoggio delle palme.
E dietro a Claudio affrontai il buio che si parava davanti, fitto, impenetrabile; e appena varcata la soglia, un buffo di vento freddo mi schiaffeggiò il volto. Procedetti senza veder nulla attorno a me; procedetti d’alcuni passi a casaccio, invano aguzzando le pupille per discernere la mia guida.
Subitamente ebbi l’impressione che il collare di ferro onde sentivami stretta la gola, si fosse spezzato; mi sentii sciolto dal guinzaglio, libero dei miei atti e della mia volontà. Chiamai Claudio due volte e nessuno rispose: lo chiamai nell’angoscia d’essere stato abbandonato da lui in quel mare di tenebre dove mi aveva trascinato, e la mia voce rimbombò sonora come dentro una caverna ed ebbi paura della mia voce. Unico partito, tornare indietro e guadagnar l’uscio, ma le braccia protese per istinto nella caliggine, toccarono quasi subito la parete.
Rasentandola, era naturale che avrei finito per incontrare lo squarcio della porta. Nulla: prima a destra poi a sinistra, il muro si allungava interminabile, gocciolante umidità dalla calce fresca che lo rivestiva; e non sapevo rendermi ragione del come mi fossi tanto inoltrato, quando ero certo di non aver fatto in principio che pochi passi. L’ansietà di raggiungere presto l’uscita, scompigliando i miei calcoli, spegnendo ogni altro pensiero, anche quello di Dio, mi faceva sembrare eterno il tragitto e aumentava man mano che la piatta superficie, sempre eguale, senza interruzioni, passava dalle tenebre nelle tenebre. Per quanto fosse vasto l’ambiente, se non avevo smarrito altresí l’ultima sensazione di cui ero capace, e nel mio turbamento non m’ingannava la falsa sicurezza della linea retta, come mai, dopo tanto percorso in uno spazio chiuso circoscritto, non riuscivo ad uno dei quattro angoli? Imboccai finalmente un’apertura, finalmente! ma non era purtroppo che il vano profondo d’una finestra nello spessore del muro; non importa, poteva essere lo scampo.
Le mie dita or non sentivano piú il ruvido intonaco sulla pietra che mi sembrava eterna, bensí scivolavano contro una lastra levigata, la percussione della quale toglieva ogni dubbio, ancorché dal di fuori non lasciasse trapelare goccia di barlume, piú opaca e piú densa che se fosse stata coperta d’un panno. Al postutto, se la spagnolotta resisteva ai tentativi e agli sforzi convulsi che facevo per aprire il telaio, i vetri avrebbero dovuto cedere sotto i miei colpi, ridotti in frantumi.
Ma sui vetri ecco apparire un riverbero luminoso, simile a quello che di notte, in ferrovia, si disegna sui cristalli dei finestrini, e nell’incerto specchio formarsi a poco a poco una macchia oblunga, come di persona in letto, che dorme. Pensai dapprima che al di là ci fosse un’altra stanza, dove tal uno avesse acceso una lampada, ma facendomi visiera agli occhi con le due mani, la fronte appoggiata ai vetri, non vidi piú nulla. Nel voltarmi rividi il chiarore dietro di me, e lontana poche braccia dalla nicchia in cui mi trovavo, una donna giacente.
Supina, coi piedi verso la parte opposta la mia, la conobbi per donna dal volume dei capelli attorcigliati sotto la nuca, aggrovigliati, aggrumati, enorme matassa color di ferro. Non le andai subito vicino, per quanto desiderio avessi di guardarla in faccia e piú ancora di sapere finalmente dov’ero. Uscito appena dai terrori del buio, la mia titubanza non proveniva da paura di quella visione e neanche da sorpresa, ma da uno sgomento nuovo, forse puerile; ho perfetta memoria del mio stato d’animo. Codesta donna era una tentazione che il demonio m’apparecchiava? E se questo non era, e alcuno fosse sopraggiunto, come avrei giustificato la mia presenza accanto al letto della dormiente? E se ella si fosse svegliata?
La curiosità mi vinse o piuttosto un impeto di ribellione alla forza occulta che faceva scempio di me. Donde piovesse la poca luce che rischiarava tanto spazio quanto ne occupava il rettangolo del letto, lo ignoro; so che non rischiarava altro; di qua, di là, nel fondo un’ombra impenetrabile.
Rigidamente, colei stava distesa, non sopra un letto, ma sopra una specie di tavolato, senza materasso, senza guanciale, fino al mento coperta d’una tela greggia che non era un lenzuolo; i piedi sporgevano fuori, ignudi, le braccia s’indovinavano incrocicchiate divotamente sul petto. La guardai in volto: una giovinetta; forse di vent’anni, o neppure; bianca, bianca, cerea, piú bianca pel contrasto dei capelli ferruginosi; violaceo il velo abbassato delle palpebre, le labbra semiaperte, livide, intorno alla chiostra dei denti. Sospettai, mi corse un gelo su nelle spalle; era morta? Il freddo che sentivo nelle ossa emanava dal suo corpo. Chinatomi per vederla meglio e ascoltare se ancora respirasse, riconobbi il pallore cadaverico e non un soffio, benché tenue, mi sfiorò la guancia. Le posai la mano
sulla fronte; nessun dubbio: era morta.
Mi sovvenni allora di Dio e caddi in ginocchio, pregando. L’opera del Signore non è mai vana: perché attraverso i prodigi inesplicabili delle sue vie, egli m’avrebbe condotto faccia faccia a un cadavere, se non per rivelarmi il miracolo infinito della sua clemenza? Pregai, non per me, ad alta voce, dinanzi al mio Crocifisso, che tenevo ritto contro la sponda di quel giaciglio e mi confortava in cosí tragica solitudine. Quanta pietà per quell’ignota, cosí giovinetta falciata a mattutino! Pregai fra i singulti, pregai desiderando, sperando, volendo qualche cosa di sensibile e di attuale, che percepivo come in lontananza e non sapevo determinare, e invece delle esequie mi sgorgava dall’anima insistente, la preghiera dei moribondi: Respice propitius, piissime Pater, Deus misericors, Deus clemens, super hanc famulam tuam in te sperantem, et non habentem fiduciam nisi in tua misericordia, ad tuae sacramentum reconciliationis admitte.
La creatura aperse gli occhi.
Son dieci giorni, monsignore, che a pezzi e bocconi vado strascicando questa lettera, dopo le prime pagine, interrotta da sonnolenze invincibili e fughe istantanee della memoria, e al sopraggiungere della sera, da una ripugnanza di star solo che somiglia al terrore dei fanciulli; e son dieci giorni che mi domando in virtú di quali meriti, io miserabile, io peccatore, fui prescelto da Dio perché assistessi a un miracolo di risurrezione, e lo vedessi compiersi davanti a me, senza alcuna meraviglia da parte mia, quietamente, come cosa che non eccede i confini naturali.
Aperse gli occhi, nuotanti ancora nella morte, e subito li rinchiuse, ferita da quel simulacro di luce. Dubitai. Dopo lunga aspettazione, li riaperse nello stupore di chi si sveglia da un sogno, spaventati e reminiscenti. Balzato in piedi, le posai di nuovo la mano sulla fronte. A quell’atto ebbe un sussulto per tutto il corpo; le sue pupille errabonde si fissarono nelle mie, quasi rifugiandovisi, assumendo un’espressione ineffabile di supplica e di fiducia. Oserei affermare che uscita dalla visione dell’eterno castigo, quell’anima rediviva riconosceva in me la potestà di liberarla? Agitate da un tremito, sembrava che le labbra tentassero uno sforzo per rivelarmi il segreto.
Rispondimi: Credi che il tuo Redentore vive, e nel novissimo giorno sorgerai dalla terra e lo vedrai coi tuoi occhi, e le tue ossa umiliate esulteranno al suo cospetto? che Egli è la resurrezione e la vita e chi crede in Lui, anche fosse morto, vivrà e non morrà in eterno? Proferii queste parole con voce ferma. La creatura che intanto non aveva battuto palpebra, tenendo lo sguardo sempre inchiodato nel mio, superò lo sforzo e dal moto delle labbra divenuto calmo e regolare, indovinai che articolava la risposta, ma cosí piano che l’udito non la percepiva. Curvo sul suo corpo, approssimai l’orecchio; non afferravo da principio neppure un bisbiglio indistinto, poi un sospiro, meno d’un sospiro, un alito che non avrebbe appannato il cristallo: ma quell’alito aveva suono e forma di sillabe, e in un linguaggio non mai ascoltato e che pure comprendevo quanto il mio, netta, spiccata, intera, raccolsi la confessione d’oltre tomba.
Appena sulla penitente feci il gesto della croce, pronunciando la formula sacramentale che l’assolveva nel nome della Sacrosanta Trinità, le sue pupille non mi videro piú, le sue labbra non mi parlarono piú, il suo corpo si irrigidí un’altra volta. Piú nulla. Claudio, che avevo dimenticato, sorto improvvisamente dall’ombra ai piedi del cadavere, stava guardandomi. Egli si mosse, seguito da me, verso il muro di tenebre, le quali a destra e a sinistra si aprirono a guisa di cortine sul nostro passaggio; e come la sua volontà mi aveva condotto in quel luogo, cosí mi trasse via per lo stesso cammino già fatto sino all’imboccatura della strada dove abito e che non tardai a riconoscere, tosto che mi accorsi d’essere stato di nuovo abbandonato dalla mia guida. Salii la scala a tentoni; trovai l’uscio socchiuso quale l’avevo lasciato nel partire, e allorché fui nel corridoio che mette alla mia stanza e, inciampando, feci rotolare una seggiola, non fu la voce di lui, di mio fratello, che intesi gridare dalla sua stanza, come quella d’un uomo svegliato di soprassalto?
A questo punto, ella dirà, padre, che non valeva la pena di importunarla, di rubarle un tempo prezioso e stancare la sua pazienza per narrarle minutamente un sogno da donnicciuola, o piuttosto una allucinazione inverosimile, prodotta senza alcun dubbio dal turbamento che nell’animo mio aveva suscitato il racconto di Claudio circa la sua inferma dell’ospedale. Credetti io pure a un sogno, e volli persuadermene a qualunque costo la mattina dopo, allorché mi destai, seduto davanti al mio tavolino, col breviario spalancato sotto gli occhi alla pagina del Benedictus; e con tanta ingenuità
me ne persuasi, da non curarmi, per progetto deliberato, di appurare talune minime circostanze, e neppure di farne cenno a mio fratello, senza rendermi conto che questo disegno, spregiudicato in apparenza, non era altro in fondo che paura bell’e buona di dovermi ricredere.
Sebbene rotto e febbricitante, dopo una misera Messa celebrata sotto l’assedio di continue tentazioni e di spasimi, non seppi risolvermi a lasciar partire Claudio solo, e l’accompagnai per trovarmi con lui sulla porta dell’ospedale, all’ingresso del nostro Arcivescovo e unirmi poi al seguito. Egli era malinconico e di poche parole. Strada facendo mi domandò: «Questa notte, chi ha suonato due volte il campanello? Cercavano di me?»
In compagnia del clero, dei membri del Consiglio d’amministrazione, dei medici primari e assistenti, dopo aver lentamente percorso ad una ad una le lunghe sale dolorose, fermandosi al letto degli ammalati piú gravi nell’uno e nell’altro riparto, confortando e benedicendo, Sua Eminenza reverendissima scese al piano del cortile. Entrammo tutti in un grande camerone, squallido, rischiarato da immense finestre coll’inferriata. Domandai dove fossimo, un giovane assistente rispose tra lo scherzo e lo scherno: «All’Eden». Cinque cadaveri giacevano sul tavolato, nascosti da una tela greggia; erano i morti della vigilia che aspettavano l’ora di essere sepolti. Monsignore manifestò il desiderio di vederli e alcuni famigli rovesciarono quel ludibrio di drappo funebre, lasciando cosí scoperti i volti, di fronte a noi: quattro uomini e una donna.
Debbo dirle che ravvisai in quella donna la giovane che io avevo confessata durante la notte, e che vidi il mio Crocifisso ancora adagiato sul suo petto. Con voce alta e sonora il Cardinale intonò l’antifona: «Ego sum resurrectio et vita…»